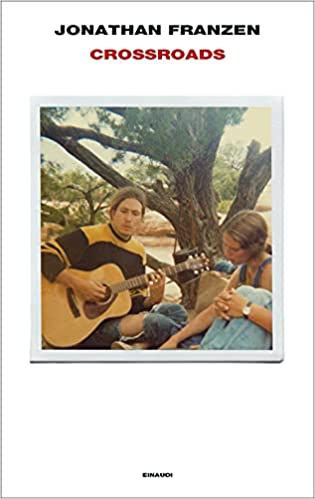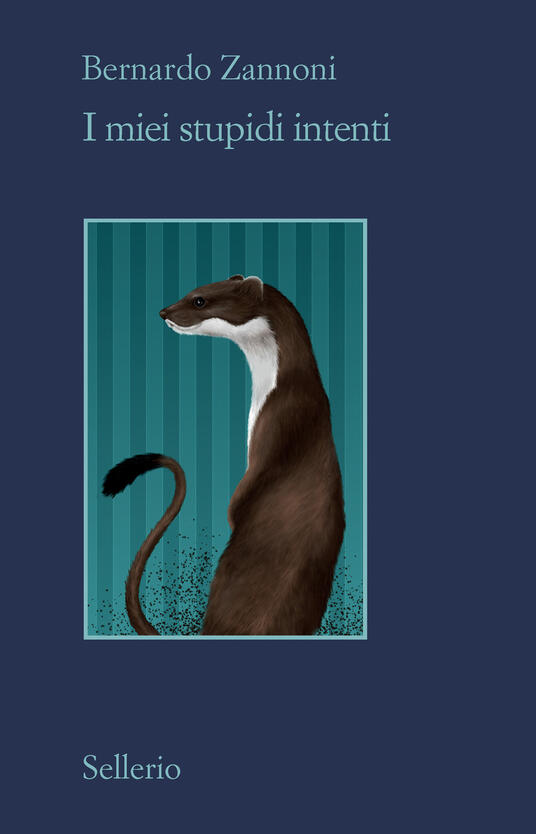Nel 1994 Alice Munro pubblica la sua ottava raccolta di racconti, Open secrets, tradotta poi in italiano col titolo di Segreti svelati (2008, pp. 282, ed. Einaudi, traduzione di Marina Premoli). Non ha ancora ricevuto il premio Nobel per la Letteratura (arriverà 19 anni dopo), ma è una scrittrice affermata, soprattutto in Nord America, dove ha vinto per tre volte l’importante premio canadese Governor’s General Award, e gode di grande consenso da parte di critici e specialisti.
Tra i racconti della raccolta si distinguono, Carried Away (Travolto dai sentimenti), per l’ampiezza e la profondità delle vicende narrate, e il racconto eponimo, che fornisce uno scorcio di tragica inquietudine sul rimosso sessuale delle rispettabili vite di una cittadina del Canada rurale. Questo senso di rimosso, di verità note a tutti ma non riconosciute apertamente, di non segreti, appunto di «open secrets» (che la traduzione italiana «segreti svelati» probabilmente non rende appieno), è il filo conduttore che unisce storie e personaggi, il leitmotiv di queste vite di paese del Novecento, così minimali, irrisolte e segnate dall’ossessione verso i desideri irrealizzati.
In questo articolo mi occuperò del secondo racconto della raccolta, A real life (Una vita vera), pubblicato originariamente su The New Yorker nel 1992, che mi ha portato a fare una serie di riflessioni sulla tecnica narrativa di Alice Munro e, soprattutto, su alcuni nuclei centrali della sua arte.
Partiamo dall’espressione usata nel titolo, una «vita vera»: un’espressione la cui apparente pretesa di assolutezza, l’ambizione di rappresentare una vita piena e autentica, contrasta con l’insignificanza e la marginalità delle esistenze rurali di cui solitamente narra Alice Munro. E, allora, chi saranno i protagonisti di questa storia? Che forma potrà mai avere, in questo racconto, una «vita vera»?
Il matrimonio, «una fortuna così smisurata»
Tutto comincia quando si scopre che Dorrie ha ricevuto un’imprevedibile proposta di matrimonio. È una donna rude e selvatica, ormai non più giovane. Ha sempre vissuto in una casa di campagna, in compagnia di un fratello altrettanto selvatico, che però è morto di recente, all’improvviso. Campa di espedienti, come dare la caccia ai topi muschiati per rivenderne le pelli, e sembra condurre un’esistenza vicina al livello della pura animalità: procurarsi del cibo, assicurarsi di avere un tetto e un letto, vivere quel minimo di relazioni sociali che le permettono di compiere i propri baratti.
La proposta di matrimonio cambia radicalmente lo scenario. L’ha ricevuta per lettera da parte del signor Speirs, un ereditiero australiano che ha incontrato una sola volta, durante una cena a casa della sua amica Millicent. In un primo momento accetta, ma non sa come comportarsi. Come si organizza un matrimonio? Come ci si prepara per il rito? Come, soprattutto, si imbastisce un abito da sposa?
«Verso la fine dell’inverno, Dorrie si presentò da Millicent con una grande pezza di raso bianco. Disse che voleva fare un abito da sposa. Quella fu la prima volta che qualcuno sentì parlare di nozze – Dorrie spiegò che sarebbero state in maggio – e udì il nome del signor Speirs. Wilkinson. Wilkie».
Chiede quindi aiuto a Millicent, la vera protagonista della storia (che è tutta narrata dal suo punto di vista, in terza persona). Millicent è una decorosa signora di mezza età, moglie dell’agricoltore Porter e madre responsabile. Al contrario di Dorrie ha un alto senso della comunità e dei simbolismi sociali della vita di paese. Quando apprende che qualcuno vuole sposare la sua amica Dorrie si chiede come sia potuto succedere, ma non ha dubbi sulla scelta più giusta: Dorrie deve accettare, sposarsi, per trasformare la sua esistenza incompiuta di nubile in una «vita vera». E quindi, assieme a Muriel, l’altro membro del terzetto al femminile, decide di aiutare Dorrie a cucire l’abito.
Dopo settimane di preparativi convulsi, ci si avvicina al grande giorno. Una settimana prima del matrimonio – il signor Speirs non è ancora tornato dall’Australia – Millicent organizza una cena, ma Dorrie tarda a comparire. Millicent teme il peggio, ha un presentimento, corre a casa di Dorrie, dove la trova intenta a prepararsi da mangiare. Sta riscaldando anche del tè alla contadina, «nero come l’inchiostro», che Millicent trova imbevibile.
Ha visto giusto. Dorrie è tormentata: non sa se vuole davvero sposarsi e abbandonare per sempre la vita di campagna che le è tanto cara. Millicent aveva intuito.
Però è decisa a convincerla. Si gioca tutte le carte, in quello che si rivela essere il dialogo epifanico del racconto. Le dice, nell’ordine: che sarebbe un peccato sprecare tutto il lavoro preparatorio fatto, che se ha paura del sesso non deve preoccuparsi troppo perché il signor Speirs è oramai vecchio, che sta reagendo in modo infantile, che la casa di Dorrie, di proprietà di suo marito Porter, è stata già venduta, cosa per cui si dichiara pronta a giurare sulla Bibbia. Dorrie, al solito testarda e di poche parole, resiste rispondendo con stringatezza. E proprio quando il confronto è all’apice e Millicent sembra aver aperto una breccia, proprio quando le cose sembrano mettersi al meglio per lei e Dorrie è pronta a capitolare, Millicent vive una repentina illuminazione sulla propria vita, sulla realtà del matrimonio con Porter e della propria vicenda umana, e scoppia in un pianto a dirotto.
Cosa ha capito Millicent nel momento in cui ha convinto Dorrie ad accettare che solo il matrimonio, «una fortuna così smisurata», possa trasformare la sua vita in una «vita vera»?
Dorrie, Millicent e Muriel
La costruzione drammaturgica del racconto, di taglio realistico con notevoli picchi di introspezione psicologica, è un meccanismo ben congegnato che ha uno scopo primario: far emergere, attraverso la tecnica del confronto, le peculiarità che caratterizzano i tre tipi femminili di Dorrie, Millicent e Muriel. Sulla scorta dei piccoli e grandi motivi di conflitto offerti dagli snodi narrativi osserviamo quindi le tre protagoniste mentre dialogano, si confrontano, si confortano e competono tra loro. Sono personaggi tanto ben individuati nelle psicologie e nei vissuti individuali quanto espressioni di figure ideali, di atteggiamenti femminili universali.
Dorrie e Millicent sono presentate sin dal principio come personalità di segno completamente opposto. Millicent ha senso sociale ed esperienza di mondo, pensa che il matrimonio e la famiglia siano il compimento della vita di una donna, organizza cene in cui tiene a mostrarsi impeccabile, nel cibo e nel servizio, sa come gestire un marito, proibendogli ad esempio, secondo una prassi non scritta ma comune al tempo, di bere alcol in casa (Porter, un bravo diavolo, risolverà bevendo alcol nel granaio).
Tanto la vita di Millicent è governata dal senso delle convenzioni e della rispettabilità, quanto quella di Dorrie è selvatica e di poche pretese. Dorrie ha una forza incredibile, che la rende un grande aiuto nello spostare i mobili o impastare il pane, spara alle marmotte e ai conigli, dà la caccia ai topi muschiati. Non ha marito né figli, vive in una casa spartana e trascurata, situata in uno dei terreni di Porter. Quando il fratello muore, lasciandola sola, lei continua in questa esistenza semplice ed essenziale. Conduce quella che Millicent ritiene una vita «misera e in un certo senso irresponsabile», non sembra afferrare nessuna delle forme sociali (il matrimonio, la famiglia, i figli, il rispetto della comunità) che per Millicent sono così importanti, ma è impossibile non scorgere nella sua quasi virile rudezza un elemento di dignità.
L’amicizia tra loro, nella raffigurazione che ne ha Millicent, è sbilanciata. Millicent dopo il matrimonio aveva mirato ad altre amicizie, ben più altolocate, la moglie del dottore e la moglie dell’avvocato, le aveva corteggiate, si era quasi messa al loro servizio, ma loro non le avevano permesso di avvicinarsi. «Avrebbe dovuto saperlo», aveva concluso lei amaramente, dopo aver recuperato il suo lucido senso delle gerarchie sociali. Dorrie invece rappresenta per lei un aiuto pratico, una persona sulla cui fedeltà si può fare affidamento, un’amicizia semplice, da gestire con condiscendenza, in cui Millicent si considera la forza trainante, l’elemento che guida in virtù della superiore capacità di giudizio (en passant, si noti l’eccellente orecchio di Alice Munro per i dialoghi, di cui il passo sotto è un perfetto esempio):
«– Dorrie è una vera signora, non importa quello che dice la gente, – diceva Millicent a Porter, che non ribatteva. Era abituato ai suoi giudizi assoluti e personali. – È mille volte più signora di Muriel Snow, – continuò Millicent, nominando quella che si sarebbe potuto definire la sua migliore amica. – Dico questo, anche se voglio un gran bene a Muriel Snow.
Porter era abituato a sentire anche questo.
– Voglio un gran bene a Muriel Snow e prenderei le sue difese in qualsiasi caso, – aggiungeva Millicent. – Voglio bene a Muriel Snow, ma non significa che approvo tutto quello che fa».
Ma durante la cena col pastore e con il signor Speirs, l’ospite misterioso venuto dall’Australia, accade la stranezza. Il signor Speirs, un tipo taciturno e bizzarro, sembra molto interessato ai racconti di vita selvatica di Dorrie, che spiega come tagliare la pelliccia di un topo muschiato e perché non sia disdicevole mangiare carne di coniglio.
Spinta dallo sguardo di un uomo, lo sguardo che può donare senso alla realtà nella vita di una donna non solo nel Canada rurale della prima metà del Novecento (e qui, come si sarà intuito se si conoscono i temi cari all’autrice, siamo in piena “zona Munro”) Millicent afferra e rivaluta certi aspetti della personalità di Dorrie. L’affetto per il suo grosso cagnolone nero, ad esempio, che Dorrie durante la cena chiama con trasporto «la mia amata cagnetta», o la passione per la caccia agli animali selvatici, che evidentemente non è condotta per soli scopi di sussistenza. La personalità di Dorrie sembra in un certo senso prendere una forma, salire di un gradino nella considerazione di Millicent.
La terza donna è Muriel, anche lei presente alla cena con il signor Speirs e parte dell’impresa di cucire l’abito da sposa. In questa rassegna così abile, variegata e ben assortita, di idealtipi femminili, Muriel rappresenta il polo della seduzione. È un’insegnante di musica frivola, tutta svolazzi e moine, suona il piano (uno dei tratti ricorrenti nei personaggi di Alice Munro, che esprime tipicamente una personalità affascinante ed esuberante), è seducente («Il termine giusto per te non è carina, ma seducente», le dice Millicent in un impeto inaspettato, di cui si imbarazza subito). Muriel fuma, fa ginnastica, dice – in modo oltraggioso – «cacca». Non si è mai sposata, ma non per mancanza di pretendenti: solo perché è esigente, quindi frequenta troppi uomini, alcuni dei quali già, a loro volta, sposati. Muriel sa cosa ci vuole per allestire un corredo matrimoniale: «camicia da notte nuziale e biancheria intima, calze di seta e un reggiseno».
Muriel si è presentata alla cena con Speirs con un vistoso abito turchese, nella speranza che l’ospite misterioso, l’amico del pastore, si riveli un tipo interessante, ma il signor Speirs si mostra subito affascinato dai racconti di Dorrie. Muriel, innervosita dall’aver clamorosamente perso la competizione contro l’avversaria più improbabile, si rende acida e pungente, esagerando con battute e atteggiamenti sfacciati che irritano la stessa Millicent. Muriel nel finale rimarrà un passo indietro, perché non sarà presente al momento del dialogo epifanico, ma sarà influenzata dalla piega presa dagli eventi.
Per chiudere con la galleria dei personaggi, va notato che il genio realistico della Munro sa dare un’individuazione precisa anche a coloro che rimangono sullo sfondo. Il pastore, la cui funzione narrativa è fare da intermediario tra Dorrie e il signor Speirs, è descritto puntutamente come «galante, o forse diventato audace per la noia», Porter durante la cena a casa sua si anima soltanto quando racconta un aneddoto, non indispensabile dal punto di vista della trama ma fondamentale nel dare corpo al personaggio, sulle corse dei piccioni.
Una vita vera
Il racconto è stato scritto negli anni novanta, ma è ambientato negli anni trenta, il periodo in cui l’immaginario di Alice Munro si è plasmato e che, anche quando rimane sullo sfondo, costituisce il termine di riferimento fondamentale delle sue opere. Lo scarto temporale potrebbe rendere la vicenda, che sembra quasi un archetipo della vita di paese dei tempi che furono, poco interessante non solo ai nostri occhi, ma anche a quelli della stessa autrice, che in altri racconti, ambientati in periodi più recenti, narra in modo ben più vivace (e audace) di come si sfasciassero famiglie e matrimoni negli anni settanta, in seguito alla rivoluzione della cultura hippy. Cosa quindi doveva dirle di così importante, e cosa ha da dire di attuale nell’epoca della rivoluzione digitale e della denuncia del patriarcato?
Chiaramente, il primo livello di interpretazione, innegabile, è quello in chiave squisitamente femminile. Le domande tradizionali e fondamentali per una donna: quali conseguenze comporta il prendere marito? A quale pezzo di sé stesse si rinuncia, e in favore di quale guadagno? Il matrimonio e la famiglia sono davvero il compimento della vita, il suo scopo ultimo?
Inutile dire che non ci sono risposte scontate. Alice Munro, da femminista nello spirito ma senza condivisione dell’impianto ideologico del femminismo, su queste tematiche torna spesso. In Vandals, un altro racconto della stessa raccolta, è presente una figura selvatica e stravagante, Ladner, quasi il corrispettivo maschile di Dorrie, un impagliatore di animali di cui la protagonista Bea si innamora. In questo caso, però, Bea sposa senza riserve la vita dell’uomo, anzi teorizza apertamente:
«In realtà, quello che pensava davvero – ben sapendo che era infantile e anche maleducato – quello che pensava davvero era che certe donne, donne come lei, erano sempre alla ricerca di una follia che potesse contenerle. Infatti, che cosa era vivere con un uomo se non vivere dentro la sua follia? Un uomo poteva avere una follia del tutto normale, invisibile, come la passione per una squadra di pallone. Ma poteva non essere una follia sufficiente, poteva non essere abbastanza grande, e una follia non abbastanza grande rende semplicemente una donna irritabile e scontenta».
Il filo rosso tra i due racconti è evidente. Adoperiamo la stessa illuminante espressione: vivere in una «follia» che possa contenerci. Nel senso che la «follia», cioè questa forma irrazionale e immotivata che assume la nostra identità, è il contenitore delle pulsioni, delle aspirazioni, degli slanci, degli impeti incontrollabili e disgregatori che costituiscono un individuo. E se un uomo può vivere «nella sua follia», perché una donna non dovrebbe poter fare lo stesso? Perché una donna dovrebbe essere contenuta nella follia dell’uomo che ha preso per marito, e non dovrebbe poter avere una propria follia, come sparare ai topi muschiati e tagliarne le pelli?
Se Dorrie quindi rappresenta questa forza motrice, che rivendica per le donne (senza in realtà farlo in modo esplicito) il diritto di fare come gli uomini, di vivere secondo le proprie inclinazioni e secondo la propria identità profonda, di vivere della propria follia, invece di cercare una follia maschile che la contenga, Millicent si batte perché ritiene che solo nell’adesione ai principi della vita famigliare, all’ombra di un uomo, una vita femminile possa trovare senso. Perché nella sua visione del mondo non farlo significa non assumere una forma adulta, rimanere confinati nel mondo dell’infanzia (non a caso, di Dorrie si rimarcano in più punti i tratti infantili, come: «Dorrie rimase ferma a riceverli [i baci] quasi avesse cinque anni» e «somigliava a quelle bambole con la testa e gli arti di porcellana attaccati al corpo di pezza imbottito di paglia»).
Come va a finire? All’apparenza vince Millicent. Quando scoppia a piangere, realizzando quanto abbia pesato, nella sua vita, la scelta del matrimonio, Dorrie corre ad abbracciarla e a consolarla. Dorrie si sposerà felicemente una settimana dopo, come da programmi, andrà a vivere in Australia col signor Speirs, trascorrendo anni felici e inviando, di tanto in tanto, delle cartoline. Muriel cambierà vita, sposandosi nel giro di un anno con un pastore, dopo aver radicalmente rinnegato la propria frivolezza. Entrambe, Dorrie e Muriel, sembrano approdare a un cambiamento di identità e alla piena realizzazione nella vita coniugale.
Nella versione dei fatti che darà a Porter, a Muriel e ad altre amiche dopo la conclusione felice Millicent si attribuirà, nel modo con cui si narrano all’infinito gli episodi destinati a diventare parte della mitologia di comunità, il merito di aver «creato una vita». «Qualcuno doveva pur affrontare il toro per le corna», dirà con compiacimento. Questa la versione ufficiale, che ben mostra la totale identificazione tra ideale comunitario e Millicent, che si spinge a paragonare il proprio atto di manipolazione alla creazione di una vita.
Ma la realtà è del tutto diversa. Il segreto è stato per un attimo scoperto, Millicent è crollata alla vista del fondo buio dietro la facciata, nero come il tè alla contadina di Dorrie. Ha capito di colpo quanto abbia pesato nella sua vita il matrimonio, quanto le sia costato, quanto penalizzante sia la bugia (l’open secret) che sta ripetendo a Dorrie, come ha fatto con sé stessa tempo prima. «Adesso devi prendere quel che viene», le ha detto Porter subito dopo il matrimonio, la notte delle nozze, e noi capiamo di colpo la centralità di questa frase, lasciata cadere con maestria da Alice Munro, senza sottolineature, all’inizio del racconto. La piena e convinta adesione all’ideale sociale si rivela per quello che è: un fardello che Millicent trascina sulle spalle, inconsapevolmente, giorno dopo giorno. Durante l’acme drammaturgico questo gigantesco rimosso impedisce persino a Millicent, fino a quel momento donna scaltra e piena di risorse, di parlare. Passato l’attimo Millicent tornerà alla versione ufficiale, alla verità condivisa con i suoi conoscenti, a buttare (anche fattualmente) il tè nero di Dorrie.
Non vince neanche Dorrie. Si sposerà, convinta dalla superiore sicurezza di Millicent o forse da una sua intima consapevolezza, che in fondo la rende non del tutto aliena all’immaginario sociale del contesto in cui vive, andrà a vivere in Australia, dove forse (ma su questo punto il racconto è significativamente elusivo) troverà una personale via alla soddisfazione in un’esistenza da esploratrice.
Già da queste considerazioni si capisce come il racconto tocchi radici molto più profonde del proverbiale tremore della sposa a un passo dall’altare. Il conflitto che Alice Munro sta tematizzando, secondo il suo approccio asciutto e antimelodrammatico, è quello perenne tra identità individuale e identità sociale, tra individuo e società, dove il primo polo è l’insieme degli slanci che ci animano sin da quando assumiamo coscienza di noi stessi e il secondo è la direzione favorita dal contesto sociale in cui viviamo, la gabbia dorata cui non ci opponiamo perché sembra non solo facilitarci la vita, ma anche donarci un senso con cui ci identifichiamo.
Uno dei temi ricorrenti nelle opere di Munro è in effetti quello della realizzazione personale, tanto più sentito e letterariamente intenso perché spesso trattato dalla prospettiva, meno emancipata, delle donne nel Canada rurale della prima metà del Novecento: ci si realizza risolvendosi nell’identità di un uomo, accettando le convenzioni sociali del villaggio, aderendo pienamente ad esse, come fa Millicent, o vivendo, in quotidiano contrasto col mondo, la propria follia, la propria stravaganza, come ha scelto di fare Dorrie? Qual è il modo più autentico di vivere il proprio rapporto con la società e le convenzioni che reprimono le aspirazioni personali premiando, al contrario, un’adesione convinta e interiorizzata? Quale delle due scelte può dirsi una «vita vera»?
Molti racconti di Munro esaminano (tipicamente dal punto di vista, e con un occhio di riguardo, per le figure femminili, ma senza disattenzioni verso le figure maschili) il percorso che gli individui compiono nell’accettare la propria identità sociale, cercando di salvaguardare alcuni pezzi della propria identità personale, quelli che stanno più a cuore o che si rivelano socialmente più accettabili: in altre parole, il percorso di maturazione di un individuo adulto. È una lotta che nelle sue opere si svolge per scarti e controscarti, lenti sviluppi e crisi repentine, sempre in maniera diversa e sempre con esiti diversi, e – in piena aderenza a un sano principio di realismo – non sembra obbedire a delle leggi generali.
Le cose dentro le cose
Qualche dato biografico conferma questa lettura. Alice Munro in molte interviste ricorda il senso di pressione sociale subito da adolescente, rispetto ad alcune passioni, prima tra tutte la scrittura, che la portavano a «distinguersi», tabù gravissimo nelle comunità rurali del nativo Ontario, in cui per le donne era mandatorio conformarsi senza resistenze. Nei suoi racconti, di riflesso, ricorre il personaggio di un’adolescente, sveglia e intraprendente ma un po’ più riflessiva di una coetanea ancora più scaltra, a cui piace leggere e scrivere, che vorrebbe proseguire gli studi ma non mostra alcuna predisposizione per i lavori pratici che ci si aspetta da una donna (e qui, per chi possiede un’indole da umanista, è difficile trattenere un sorriso) e che non sembra neanche avere troppa fretta di trovare un marito. Un personaggio evidentemente autobiografico, se non fosse che una delle grandi qualità di Alice Munro narratrice è la fermezza nel tenere a bada ogni intrusione dell’ego dell’autore. Lo scrittore americano Jonathan Franzen, tra i suoi grandi estimatori, ha scritto in un famoso saggio che «Alice Munro racconta sempre la stessa storia», e la storia è proprio questa qui. Ma la racconta con misurata e impietosa vividezza, nelle mille possibili varianti che essa può assumere, girando attorno ad alcuni nuclei tematici fondamentali alla base della sua produzione letteraria: come, appunto, l’imperativo sociale che rischia di allontanare l’uomo dall’integrità personale, il conflitto tra individuo e società. Tutto questo, va sottolineato, avviene in un quadro dalle tinte assolutamente antiromantiche: come abbiamo visto, Dorrie si inchina (e con lei Muriel) al suo destino di donna, nei racconti di Munro non c’è spazio né per le idealizzazioni né per i conflitti tra assoluti. Anzi, risuona una nota cinica di fondo, tanto più notevole perché capace di bilanciare il generale clima di immedesimazione empatica con i personaggi.
Jonathan Franzen sottolinea anche un’altra cosa, ancora più interessante, sull’arte di Alice Munro. Riprendendo questa dichiarazione della scrittrice, poco incline alle teorizzazioni, rilasciata durante un’intervista:
«La complessità delle cose – delle cose dentro le cose – mi sembra infinita. Voglio dire che non c’è niente di facile, niente di semplice».
Franzen evidenzia che Munro sta esponendo quello che lui chiama «l’assioma fondamentale della letteratura, il nucleo del suo fascino»; precisamente, «le cose dentro le cose». La mancanza di atomicità dei fatti alla base delle storie, che sono invece sempre suscettibili di scavo e di (re)interpretazione, magari variando punto di vista, e l’idiosincrasia per un certo modo di fare letteratura, basato sulla grandiosità degli eventi e sulla portata dei conflitti narrativi, che invece, proprio a causa della loro ingombrante dimensione, possono oscurare e mascherare la profondità delle cose. In altre parole, viene ribaltata la classica accusa rivolta ai racconti della scrittrice canadese dai detrattori: il minimalismo delle vicende, quasi tutte private e ordinarie, risulta essere invece la condizione essenziale per l’applicazione di una potente lente di ingrandimento sulle verità profonde delle nostre vite, in modo che la storia insignificante e dimenticata di un matrimonio in tarda età possa ben diventare il prisma che ci permette di riflettere sui sacrifici personali che ci hanno portato a vivere una «vita vera».
Nell’arte di Alice Munro non ci sono finali chiaramente riconducibili a un principio rivelatore, non ci sono segreti svelati. Ci sono piuttosto “open secrets”: quelle grandi verità che sappiamo e contemporaneamente non sappiamo, che potremmo intuire, e in fondo sono sempre presenti nel sommerso delle nostre coscienze, ma che non ci piace riconoscere, la realtà della nostra vita nella comunità, delle nostre aspirazioni più riposte, dei motivi che ci hanno spinti alle scelte determinanti delle nostre esistenze. E non dovrebbe essere questo uno degli scopi della grande letteratura moderna? Svelarci questi segreti “aperti”, nella loro incontestabile evidenza ma anche, questo il punto chiave, nella loro irrisolvibile opacità, nel loro essere neri come il tè alla contadina che non riusciamo a trangugiare?